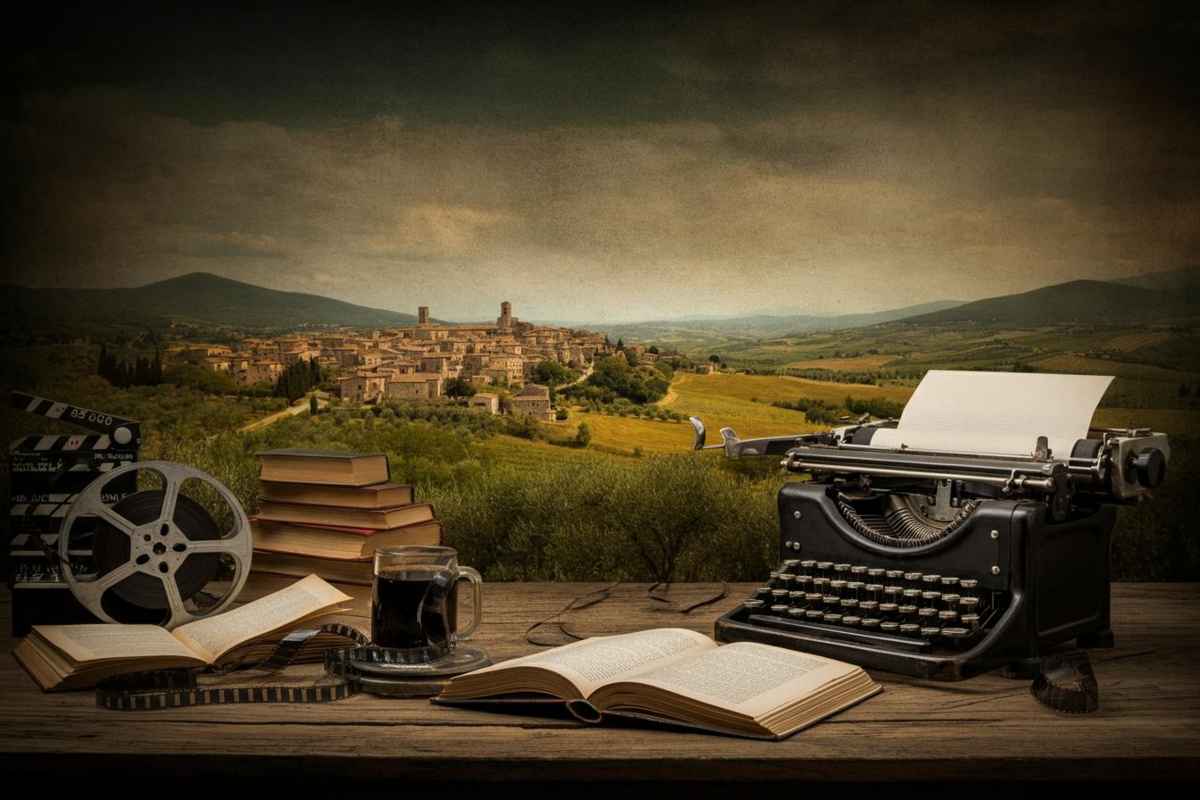È con profonda tristezza che il mondo culturale italiano piange la scomparsa di Goffredo Fofi, un critico cinematografico e letterario che ha segnato indelebilmente il panorama intellettuale del nostro paese. Fofi è deceduto all’età di 88 anni, lasciando un’eredità di pensiero libero e provocatorio che continuerà a influenzare generazioni di artisti, scrittori e pensatori. Nato a Gubbio, in Umbria, il 15 aprile 1937, Fofi si è sempre distinto per la sua capacità di andare controcorrente, sfidando le convenzioni e proponendo una visione del mondo che metteva in discussione le narrazioni dominanti.
I primi passi nella carriera di Goffredo Fofi
La carriera di Fofi è iniziata precocemente: a soli diciott’anni, si trasferì a Palermo per unirsi a Danilo Dolci nelle sue battaglie per i diritti dei disoccupati e per il riscatto delle classi meno abbienti. Questo impegno giovanile per la giustizia sociale ha segnato profondamente la sua formazione, portandolo a sviluppare una coscienza critica che avrebbe caratterizzato tutta la sua vita. Negli anni ’60, Fofi si spostò a Parigi, dove contribuì alla rivista di cinema Positif, entrando a contatto con il fervore culturale e politico di quel periodo.
L’importanza delle riviste e del dibattito culturale
Tornato in Italia nella seconda metà degli anni ’60, Fofi fondò insieme a Piergiorgio Bellocchio e Grazia Cherchi i Quaderni piacentini, una rivista che ha rappresentato un punto di riferimento per il dibattito culturale e politico. La sua attività editoriale non si è fermata qui; ha fondato e diretto numerose altre riviste, tra cui Ombre rosse e Lo Straniero, quest’ultima pubblicata fino alla fine del 2016. Il suo contributo alla rivista Linea d’ombra ha ulteriormente consolidato la sua reputazione di intellettuale innovativo e impegnato.
Fofi è stato un collaboratore prolifico di diversi giornali, tra cui Avvenire, Il Manifesto, L’Unità e Il Sole 24 Ore, dove ha trattato temi di grande rilevanza culturale e sociale. La sua penna è stata determinante nella rivalutazione di figure iconiche della cultura italiana, come Totò, a cui ha dedicato un libro insieme a Franca Faldini, compagna di vita dell’attore napoletano.
Un’intensa passione per il cinema e la scrittura
Un’altra delle sue passioni è stata il cinema, al quale ha dedicato gran parte della sua carriera. I suoi studi su personalità come Alberto Sordi, Marlon Brando e il regista Mario Monicelli hanno offerto nuove prospettive e approfondimenti su questi giganti del grande schermo. Insieme a Morandini e Volpi, Fofi ha pubblicato nel 1988 una Storia del cinema, un’opera che ha rappresentato un importante contributo alla critica cinematografica.
Tra le sue prime opere, L’immigrazione meridionale a Torino (1964) è emblematico del suo approccio critico e della sua attenzione ai temi sociali. Anche se inizialmente rifiutato da Einaudi, il saggio è stato poi pubblicato da Feltrinelli, segnando l’inizio di una lunga e prolifica carriera editoriale. Altre opere significative includono:
- Salvare gli innocenti. Una pedagogia per i tempi di crisi
- Strana gente. Diario tra Sud e Nord dell’Italia (1960)
- Elogio della disobbedienza civile (2015)
- Il cinema del no. Visioni anarchiche della vita e della società (2016)
- Il secolo dei giovani e il mito di James Dean (2020)
Fofi ha continuato a scrivere e riflettere su temi contemporanei fino alla fine della sua vita, con opere come Volare alto volare basso, coautrice con Letizia Battaglia, e i saggi Cari agli dèi e Quante storie. Il ‘sociale’ dall’Unità a oggi. Ritratti e ricordi (2024), che offrono uno spaccato della società italiana e delle sue trasformazioni.
La scomparsa di Goffredo Fofi lascia un vuoto incolmabile, ma la sua eredità continuerà a vivere attraverso le sue opere e il pensiero di chi lo ha seguito e ammirato. In un’epoca in cui il dibattito culturale è spesso polarizzato e superficiale, la sua voce critica e il suo impegno per la giustizia sociale rimangono un faro per tutti coloro che credono nel potere della cultura come strumento di cambiamento.